SUPER SANTOS – Abeijon, il poster e il falegname

Nelson Abeijon in una immagine recente
“Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio” diceva con l’aria strafottente di chi sa di avere in pugno l’interlocutore, dominandolo con lo sguardo fermo, lasciandolo spiazzato a rimuginare sul senso della risposta, Josè Mourinho. Non so cosa abbia provato il giornalista che lo stava intervistando. Penso un leggero imbarazzo. “Poteva rimanerci secco” mi dico. Non è un’esagerazione: immaginate di aver trattato per diletto o lavoro questo sport, alienandovi dal mondo per poi sentirvi dire una frase del genere. Non è facile, mette in dubbio tutto il mondo e le impalcature col quale l’hai faticosamente creato.
Cammino per la strada chiedendomi quanto sia giusto sapere cosa avviene a livello sportivo in Italia e in particolare in Sardegna. Che senso ha scrivere di sport a livello sociale? E’ utile o meno continuare a bombardare di notizie un lettore quando tutto sembra andare a rotoli? La crisi economica incombe, i tuoi amici vivono senza certezze e impauriti dal futuro partono a Londra per fare i lavapiatti, la classe dirigente guida un paese con una benda negli occhi e gioca a Risiko con i destini di un popolo chiuso nella gabbia opprimente dei vari social. Volto l’angolo ed entro in un bar per chiedere un caffè. Il tuo ex compagno di scuola, talento inespresso, è finito a fare il barista. Mi parla delle ultime partite del campionato di Serie D chiedendomi qualche news sul Budoni, sua ex squadra. Annuisco, smorzo i toni e chiedo il conto vedendo il passato prendere a calci il presente, facendo gol in un bicchiere sporco da lavare. Si esulta per poco. Ritorno indietro nel tempo, al marzo dell’anno scorso quando iniziai a lavorare per SardegnaSport.com, i primi articoli e le conferenze stampa, la meraviglia condita da un filo di emozione per le domeniche allo stadio vissute non più da spettatore ma da cronista. Con passi rapidi, ripercorro le tappe che hanno segnato questa strana “Vuelta”.

Abeijon esulta al Sant’Elia
Mi vedo come uno scalatore che arranca in salita e arriva stremato al traguardo, stanco ma soddisfatto. Abbozzo un sorriso mentre continuo la mia camminata in viale Dante, a Sassari. Chiedo all’edicolante uno “Sportweek”, abbasso lo sguardo verso la copertina, incuriosito. “I soliti volti” mi dico. “Gli stessi campioni ogni settimana, seppur in salse diverse”. Già, i campioni acclamati, osannati dalla folla, usati e gettati nella “Geenna” del dimenticatoio. Riposti in soffitta, nella quale vivono stipati e impolverati insieme ad altre riviste, altre prime pagine, primi piani che il tempo ha logorato riducendo una leggenda in carta straccia, buona solo per incartare il pesce o accendere il fuoco del camino di un casolare di campagna. Eppure qualcosa sarà rimasta, non può limitarsi un’intera carriera ad un paio di titoli dimenticati di un giornale che nessuno leggerà più. Un segno del loro passaggio dovrà pur essere rimasto.
Mi chiedo che fine abbia fatto Nelson Abeijon, unico poster rimasto appeso nella bottega di un falegname, amico di mio padre, dal giorno del suo addio. M’illumino di colpo. Un lampo mi abbaia e tra i tram che passano e le vite che scorrono nel frastuono del traffico, realizzo perché sia un bene scrivere di sport: perché gran parte della nostra esistenza è stata scandita da un avvenimento che funge da segnalibro e spartiacque nelle pagine del vissuto. Parlare di sport può diventare rappresentazione di un ricordo che prende vita e corre sulla fascia scappando dai paletti dell’attualità. Dentro una storia può esserci il volto di tutti, di ogni singolo lettore. Dalla foto in bianco e nero di un numero 7 dalla maglia sgualcita e rattoppata “alla buona” può affiorare un aneddoto, il volto di un parente perso del quale non rimane altro che polvere e affetto. Questa rubrica è inusuale, può piacere o non piacere. E’ un percorso, una camminata di un giorno, tra Cagliari e Sassari passando per l’interno, o in un posto remoto dell’America Latina, in una piazza di notte, una taverna fuori mano per dialogare amabilmente di calcio e sport in maniera diversa, inedita, come se fossi seduto in mezzo ad amici, dialogando in maniera animata tra una sigaretta e una birra, una battuta al barista e una velata malinconia che affiora dal fondo di un bicchiere mentre mi soffermo a pensare insieme a voi. Sì, fate come se fossi un vecchio compagno di ventura, al ritorno da un lungo viaggio che racconta una storia per qualche minuto, niente di più. Questa rubrica è il tentativo di una ricerca, un’introspezione, una speranza affinché la forza del ricordo e della narrazione possa resistere e scongiurare, in qualche modo, la caducità del tempo che avanza.
Nelson Abeijon, come già detto, è l’unico poster rimasto appeso nella bottega del falegname Michele, insieme ai calendari di Eva Henger (apprezzatissimi dai clienti di ogni età e classe sociale) e delle biondissime modelle della Wurth. Cosa ci facesse non l’ha mai capito nessuno sopratutto perché l’artigiano tutto era tranne che un tifoso del Cagliari. Agnostico per natura, credeva unicamente (con punte di fondamentalismo) nella Juventus. Manifestava il suo amore per il club torinese con ogni orpello raccattato in strada. Portachiavi, zebra appesa sul cruscotto insieme al cavallino rampante Ferrari davano vita a valzer scoordinati e da censura dovuti agli scossoni del cambio repentino di marcia o all’accelerazione improvvisa dopo la curva, sulla sua Fiat 127 amaranto che gli era valsa une mezza presa in giro e un paio di pernacchie al bar dopo l’acquisto. Immancabili le cravatte bianconere, rispolverate in occasioni importanti come battesimi e cresime destavano l’imbarazzo dei familiari e accese discussioni con amici in netta opposizione con i suoi gusti, non solo estetici. Si rendeva conto di creare dissenso e di essere costantemente fuori luogo. Non si preoccupava, anzi gongolava sorridendo alla James Coburn, lasciando intravedere i denti bianchi costellati di macchie giallastre di nicotina, racchiusi nella cornice di baffi arcigni, “alla Benetti” (roccioso mediano bianconero degli anni ’70) come diceva lui, i quali celavano abilmente i segni rimasti da una vendicativa acne giovanile mal curata. Era innamorato della “Vecchia Signora”, quella della Mole avete capito bene, ma rimaneva legato, profondamente, a Nelson Abeijon. “E’ un uomo con le palle”, sibilava, “uno dei pochi rimasti in mezzo a queste donnette che si truccano prima di entrare in campo”. Tempo dopo capii il motivo per il quale tenne il volto dell’uruguagio appeso nella sua officina per così tanto tempo. Ci arriveremo con calma.
Conobbi il mediano nato a Montevideo un pomeriggio di fine estate del 2005. Il Cagliari affrontava, a San Teodoro, la formazione di casa per celebrare l’inaugurazione dell’impianto sportivo e del manto in sintetico di terza generazione, assoluta novità per l’epoca nel Nord Sardegna. In panchina sedeva, col suo ciuffo brizzolato, il romagnolo Daniele Arrigoni, esonerato dal Torino nel ritiro estivo e richiamato a Cagliari tra i mugugni della tifoseria dopo la cacciata di Attilio Tesser. Andrea Cossu era appena tornato da Verona, Daniele Conti un 27enne prossimo ad indossare la toga di senatore. Nelson Abeijon, quel 3 settembre, il meglio di sé lo diede nel terzo tempo, prendendo dalla miriade di mani di bambini appaiati nella morsa della rete di recinzione (tra le quali comparivano quelle di mia sorella), pennarelli e maglie che prontamente consegnava ad ogni singolo giocatore, costringendolo, a muso duro, ad apporre una firma, lasciando intravedere un sorriso malcelato pronto a tradirlo in una sonora risata.

Abeijon sfoggia una maglia in onore del tifoso Valery Melis
Era un giocatore giunto alla fine dei suoi giorni calcistici, un Aiace dalle gambe distrutte per i colpi, dati e ricevuti, nel corso della carriera. Fu proprio quello il suo ultimo anno in maglia rossoblù. Alla fine della stagione 2005/2006 il presidente Cellino non gli rinnovò il contratto, lui alzò i tacchi e partì con le lacrime agli occhi verso il nord Italia, nella fredda Bergamo per poi eclissarsi nel cielo della sua infanzia, la stagione successiva, al River Plate di Montevideo. Aveva dato i primi calcio al pallone nella “cantera” del Nacional, il glorioso club della capitale nel quale aveva militato “la meravilla negra” José Leandro Andrade, parte della rosa campione del mondo nel 1930 e i gregari del clamoroso Maracanazo vinto, nel 1950, contro ogni aspettativa davanti ai quasi 200.000 di Rio de Janeiro in lacrime. L’esordio in campionato avvenne nel 1993 a 20 anni, nella squadra illuminata dal talento cristallino di quel futuro rossoblù che anni dopo consiglierà Cellino di portarlo nell’Isola insieme a Diego Lopez: Fabian O’Neill. I tre erano entrati in contatto durante il ritiro della Copa América, nel 1995, nella Celeste trainata da altri due ex cagliaritani: Daniel Fonseca e ed Enzo Francescoli (miglior giocatore del torneo).
Con Diego, “hermano màs que amigo” (più un fratello che un amico), si ritrovò prima all’aeroporto di Santander, nel Racing, in una Primera Divisìon Spagnola datata 1997-98, poi ad Elmas la stagione successiva. A Cagliari si respirava aria di casa, ma gli inizi non furono facili. Era come se fosse ritornato al passato, indietro nel tempo, al Nacional di 5 anni fa: O’Neill in mezzo al campo ad infiammare l’arena con tocchi di fino e sventagliate di 40 metri (sobrietà permettendo), lui in panchina ad osservarlo, sperando di trovare posto. Giampiero Ventura non aveva visto di buon occhio gli acquisti uruguayani, non riconoscendo loro un particolare talento. Lopez e Abeijon i primi due anni giocarono poco ma lavorarono tanto per sopperire alle lacune tecnico-tattiche. Si umiliarono arrivando a svolgere mansioni proprie di un magazziniere o di un raccattapalle. Immaginate un energumeno di 26 anni, un gigante buono di 1.86 cm che non parla una parola di italiano, giocare raramente e, nonostante tutto, sfoggiare il miglior sorriso e portare le borracce ai vari Berretta e De Patre, titolari al suo posto.
Umiltà e perseveranza, le sue doti migliori erano queste. I tifosi lo capirono, dalla prima partita fu uno di loro. Trovò più spazio in Serie B, con la carrellata di allenatori succedutisi negli anni bui, poi il ritorno in Serie A dopo che quello di Ventura a Cagliari lo aveva riportato tristemente indietro nel tempo. Spedito a Como d’estate (2003-2004), cacciato nel peggiore dei modi, fece il ritorno a casa con Edy Reja e li nacque la storia del “Guerriero”. Zola lo illuminò, gli levò qualche grattacapo di troppo e Abeijon risorse ancora una volta. Fu un altro giocatore, più maturo e intelligente in campo. Carismatico, dall’esuberanza contagiosa, come un bambino iperattivo. Altre due stagioni in riva al Golfo degli Angeli e quel 3 settembre 2006 sulla rete a raccogliere gli autografi dei compagni di squadra per darli ai bambini. Mi chiesi chi glielo facesse fare, in fin dei conti. Mia sorella alla fine ebbe la maglietta autografata, lui la mise all’ultimo momento quasi dimenticandosi di essere anche lui uno dei “famosi”. Colpisce la storia di Abeijon. Non stiamo parlando di un eroe epico alla Riva, un antieroe sregolato alla O’Neill, ma di un uomo come tutti. Un padre di famiglia pronto a difendere la figlia, un gregario capace di spingersi oltre i propri limiti arrivando a vette impensabili.
Michele, intanto, stava per mostrare i titoli di coda alla sua vita. La Juve che, dopo il purgatorio della cadetteria, non ingranava contribuì a mandarlo al tappeto anzitempo. Prima che chiudesse bottega, una sera a fine giornata, andai a bussare alla sua porta per chiedergli se potevo avere quel famoso poster visto così tante volte gridare in mezzo al truciolato di quella falegnameria decadente. S’inchinò e mi guardò dritto negli occhi. Rimasi immobile senza battere ciglio. Ruppe il silenzio dicendo: “Siediti, ti racconterò la storia di Abeijon”. C’era tutta la sua vita in quel racconto, gli anni umilianti nel servizio militare, una sorella malata da accudire quotidianamente al ritorno, qualche gol fatto nel corso degli anni ma sopratutto tanto duro lavoro e poche onorificenze. “Sono stato un mediano come lui. Un mediano nella vita. Nel volto sono Benetti, tutti i giorni sono Abe provando a non soccombere, lottando e arrancando di continuo, senza sosta, per un tozzo di pane. La prima volta che vidi questo bestione esultare, ero al bar con tuo padre e alcuni suoi amici. Era contro il Crotone, non voglio sbagliare. All’inizio risi, poi mi accorsi che quella scena aveva ben poco di comico. Era rabbioso, aveva tanta di quella grinta mentre correva verso la curva, come se fosse inglobata da anni pronta ad esplodere. Mi colpii, lo presi in simpatia, diventai nel tempo un suo estimatore. I suoi gol erano una liberazione, una vendetta contro qualcuno.” Non proferii parola. Era uno di quei momenti nei quali non parlare è consigliabile e opportuno. Staccò il poster dal muro, l’arrotolò, lo racchiuse in un elastico scovato in mezzo a chiodi e cacciavite e me lo diede mettendomi una mano sulla spalla. “Appendilo dove vuoi, ricordati di lui, ricordati di me”. Era sul punto di commuoversi, lo ringraziai a testa bassa e scomparsi lasciandolo dietro alle mie spalle.
Il poster di Michele che grida è l’unico appeso in stanza. Ormai non c’è solo Abeijon racchiuso in quel foglio, c’è dentro la storia del falegname, potrei esserci io e tutti i mediani che quotidianamente lottano in mezzo al fango con i calzettoni inzuppati per proteggere la propria metà campo, per strappare il pallone dai piedi di quel dieci molto più forte e tecnico. Ci son tutte le urla di coloro che non si fermano dopo un contrasto violento, quelli che si rialzano stringendo i pugni un’altra volta e ci riprovano, pur non avendo piedi per impostare, rapidità nel scegliere in fretta ciò che è giusto fare. Ci sono infine quelli che per gran parte della loro vita hanno sacrificato se stessi e le proprie gambe per la squadra, per il bene comune, guidati dall’utopica certezza di farsi strada unicamente col sacrificio, aggrappandosi al sogno di fare il gol della vita dribblando tutti, anche per una sola volta. C’è la voglia di rivalsa, la “garra” per dimostrare ai detrattori di sempre che dietro un semplice volto da criticare c’è un racconto non conosciuto, all’interno di una una maglia naufraga un passato difficile da contenere, dietro un’esultanza una tormenta covata nel tempo, un pianto dimenticato, stagnato nella triste accettazione di dover dar luogo ad un’incessante lotta, infinita, perché questa vita è bastarda nel toglierti le certezze dai piedi, facendoti penare inutilmente.
Si, quel poster racchiude tante storie, oltre a quelle dei due protagonisti di questo racconto, i quali non riesco più a slegarli l’uno dall’altro per via delle loro vite simili, ora intrecciate. Li confondo, li vedo correre fianco a fianco come compagni di squadra in un campo assolato, in terra battuta, alla fine del mondo. Hanno subito un altro gol ma non demordono. Raccolgono il pallone finito in rete e si dirigono verso la meta campo con fare deciso. “L’importante è reagire subito, non farsi sopraffare. Perché per ogni contrasto perso ce ne sarà uno vinto, per ogni gol subito c’è sempre un fischio che fa re-iniziare tutto daccapo”. Mi direbbero queste parole, ne son certo, e lo farebbero allontanandosi a testa alta, con il passo deciso di due vecchi mediani pronti a combattere una nuova battaglia.
Fiorenzo Pala







 Iscriviti al feed RSS
Iscriviti al feed RSS
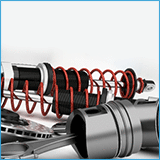











Commenti